Giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio del 1995 a Srebrenica, 11 luglio 2025
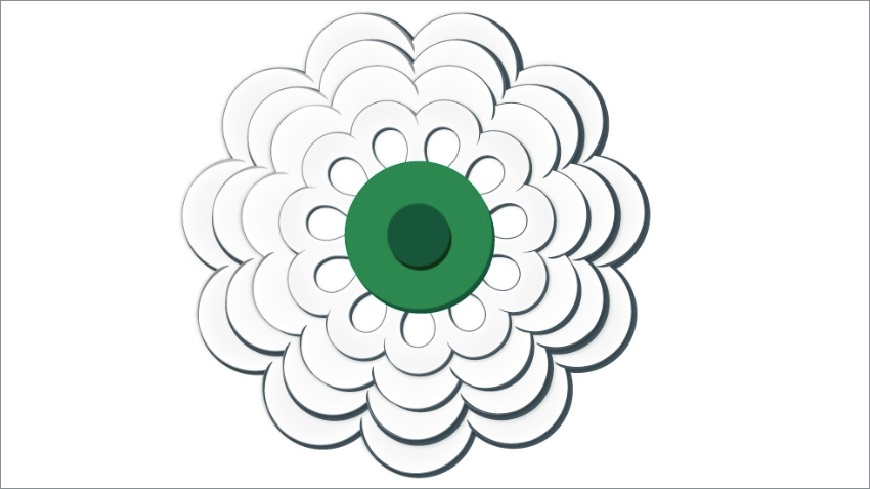
L’11 luglio 2025 ricorre il 30esimo anniversario del genocidio di Srebrenica, avvenuto nel 1995 per mano delle forze militari serbo-bosniache e sotto lo sguardo di una comunità internazionale inerte. Tale evento storico, insieme al genocidio del 1994 in Ruanda, ha esercitato un’influenza determinante per l’evoluzione del diritto penale internazionale e l’assunzione di un reale impegno a livello mondiale per la prevenzione dei genocidi. Nel maggio 2024, su iniziativa della Germania e del Ruanda, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/78/282, proclamando l'11 luglio Giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica. Lo scopo è di rimarcare l'importanza di mantenere viva la memoria di questo evento e di comprendere la dimensione profonda dei processi sociali e politici che crearono il terreno fertile per la sua perpetrazione. Allo stesso tempo, si vuole evidenziare come questi stessi processi oggi ostacolino il superamento di un trauma collettivo ancora latente nella società.
Tra gli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000 i Balcani furono interessati da una serie di conflitti armati favoriti dall’ascesa dei partiti nazionalisti e dalla forte destabilizzazione determinata dalla dissoluzione dell’entità ex-jugoslava. La Bosnia-Erzegovina, caratterizzata allora da un tessuto socio-culturale estremamente multiculturale, fu teatro della guerra più duratura e sanguinosa tra i tre maggiori gruppi etno-nazionali, i serbo-bosniaci, i musulmano-bosniaci e i croato-bosniaci. Nella parte orientale del paese, dove si trova Srebrenica, l’esercito serbo-bosniaco attuò in modo sistematico una campagna di pulizia etnica nei confronti della popolazione civile musulmano-bosniaca col fine di rendere quell’area etnicamente omogenea e, conseguentemente, annetterla alla Serbia. A partire dal 1992 Srebrenica divenne un’enclave sotto il comando dell’Esercito della Repubblica della Bosnia-Erzegovina, a maggioranza musulmano-bosniaca. Ciò contribuì ad attirare migliaia di civili in fuga dai territori circostanti, aumentando vertiginosamente la concentrazione demografica della città e innescando una crisi umanitaria senza precedenti. Dinanzi a questa situazione catastrofica il 16 aprile 1993 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la risoluzione 819 che designava Srebrenica “zona sicura”, a cui fece seguito un accordo di cessate il fuoco in cui veniva imposta una smilitarizzazione dell’area monitorata dalle Forze di Protezione delle Nazioni Unite (UNPROFOR). Queste ultime stabilirono la loro base di comando a Potočari, distante circa 5 chilometri dall’enclave. L'insufficienza numerica e l'impreparazione delle truppe presenti, unite all'inadeguatezza delle soluzioni proposte ai vertici e all'inerzia della comunità internazionale, spianarono la strada alle truppe serbo-bosniache.
All’inizio di luglio 1995 il generale Ratko Mladić lanciò l’offensiva “Krivaja 95”, che si concluse con la conquista di Srebrenica l’11 luglio 1995. La sua imminente caduta spinse circa 30.000 civili a cercare rifugio: la maggior parte donne, bambini e anziani, insieme ad alcuni uomini, si diressero verso la base ONU a Potočari. Nel frattempo, la maggioranza degli uomini in età da combattimento tentò disperatamente di fuggire attraverso i boschi circostanti, puntando a raggiungere il territorio controllato dall'Esercito della Repubblica della Bosnia-Erzegovina. Raggiunte dalle forze serbo-bosniache, i primi vennero deportati, mentre i secondi furono detenuti e poi metodicamente assassinati. I loro corpi furono seppelliti in numerose fosse comuni, per poi essere barbaramente spostati e seppelliti nuovamente alcuni mesi dopo in fosse secondarie e terziarie dalle truppe serbo-bosniache per occultare i crimini commessi. Le vittime furono più di 8000 e ad oggi diversi resti rimangono dispersi, privando le famiglie della possibilità di dar loro degna sepoltura e del diritto di conoscere il destino dei propri cari. La natura genocida di questi eventi venne confermata sia dal Tribunale Penale Internazionale per l’Ex Jugoslavia (ICTY) sia dalla Corte di Giustizia Internazionale (ICJ). Per i crimini perpetrati a Srebrenica furono giudicate colpevoli 16 persone, tra cui Radislav Krstić, Ratko Mladić e Radovan Karadžić.
L’8 luglio 2025 gli alti funzionari delle Nazioni Unite e alcuni sopravvissuti al genocidio di Srebrenica si sono riuniti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per commemorarne insieme il trentesimo anniversario. I funzionari hanno manifestato preoccupazione per il frequente negazionismo del genocidio e la persistente glorificazione dei criminali di guerra, che possono esacerbare le fratture ancora esistenti nella società bosniaca e minare il percorso verso la riconciliazione. Il Presidente dell’Assemblea Generale Philémon Yang ha sottolineato l’importanza dell’educazione nel contrastare il revisionismo storico e la ripetizione di tali atrocità, elemento ripreso anche dal Segretario António Guterres, che ha denunciato l’esistenza di paralleli inquietanti tra il contesto attuale e i meccanismi socio-politici che precedettero il genocidio di Srebrenica.

