La cultura del pacifismo di fronte alla sfida dell’aggressione ai popoli: il diritto-dovere di ingerenza umanitaria
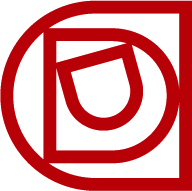
La politica internazionale mostra segni di schizofrenia, con gravissimo pericolo per tutti. Si invocano principi nuovi, anzi rivoluzionari, come quello di ingerenza umanitaria negli affari interni degli stati, ma li si interpreta e li si applica utilizzando procedure e strumenti che sono incompatibili con la ragione profonda dei principi invocati. Asserire che è lecito e giusto intervenire negli affari interni di uno stato significa minare le fondamenta del pluricentenario diritto che regola i rapporti fra stati, cioè il principio di sovranità di cui è logico corollario il principio di non ingerenza negli affari interni.
Come si legittimano gli atti di ingerenza e, prima ancora, sono necessari ed utili tali atti? Nessuna risposta è plausibile, se non ha come parametro di riferimento quello dei diritti umani, un parametro che è allo stesso tempo etico e giuridico. Quando i diritti fondamentali delle persone, dei popoli e delle minoranze sono violati e lo stato sul cui territorio avvengono le violazioni è manifestamente indisposto o incapace di tutelarli, si crea una situazione di necessità o di emergenza per l’intera comunità internazionale. Ciò avviene, deve avvenire, perchè i diritti innati delle persone e dei popoli sono riconosciuti come diritti fondamentali dal nuovo diritto internazionale o diritto della famiglia umana universale. Le principali fonti di questo sono la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, le due Convenzioni giuridiche internazionali del l966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, e altri cinquanta accordi giuridici, ultimo dei quali (1989) la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dei minori.
Il rispetto dei diritti umani fa oggi parte di una materia che ha per così dire oltrepassato le Colonne d’Ercole della «giurisdizione domestica» degli stati. La violazione anche di un solo diritto umano nei confronti anche di una sola persona costituisce crimine ai sensi del nuovo diritto internazionale. La comunità internazionale ha quindi l’obbligo di mettere in atto modi e mezzi appropriati per fare rispettare le nuove norme giuridiche che essa ha stabilito. Il principio che presiede alla realizzazione di questo dovere di intervento è pertanto quello della eguale dignità di tutte le persone umane: a questo principio cede la sovranità degli stati, come avviene all’interno degli ordinamenti ‘costituzionali’ degli stati, ove è solennemente statuito che la sovranità appartiene al popolo (in virtù dei diritti innati di ciascuno dei suoi membri), non allo stato. In virtù della normativa internazionale sui diritti umani è dato asserire con certezza, in punto di logica e di diritto, che esistono valori, diritti e interessi umani i quali sono superiori ai diritti e agli interessi degli stati.
Sollecitata e alimentata dai grandi processi di mutamento in corso nel pianeta (nel segno del bene e del male), si sta svolgendo quella che possiamo considerare la lotta titanica tra il vecchio diritto internazionale delle sovranità statuali armate e il nuovo diritto internazionale della famiglia umana universale, tra gli operatori della cultura dell’interesse nazionale e degli equilibri di potenza da un lato, e gli operatori della cultura della promozione umana e della solidarietà in ogni parte del mondo, dall’altro. La schizofrenia del momento, cui accennavo in apertura, discende dal fatto che esistono formalmente due parti dell’ordinamento giuridico internazionale, ambedue poste in essere dagli stati ma fra loro radicalmente incompatibili.
La soluzione del problema di un nuovo ordine internazionale più giusto e solidale, cioè più umano, sta nel favorire la vittoria del nuovo diritto dei diritti umani sul vecchio diritto delle sovranità statuali armate, cioè nel riuscire a non fare applicare i vecchi principi e nel subordinare le norme relative allo status internazionale degli Stati a quelle relative allo statuto internazionale delle persone e dei popoli.
La condizione schizofrenica della politica internazionale è speculare allo stato di confusione che caratterizza il dibattito in corso nei grandi mezzi di informazione: le grossolane accuse di «due pesi, due misure» nei confronti delle prese di posizione di Giovanni Paolo II – «contro» la Guerra del Golfo e «per» l’intervento umanitario, ovunque ce ne sia bisogno – dimostrano ignoranza e mala fede, forse più la prima che la seconda. La posizione pacifista del Papa è rigorosamente coerente in sè e coi principi del nuovo diritto internazionale. La guerra in quanto tale è proscritta dalla Carta dell’ONU e, ancor più esplicitamente, dalla normativa internazionale dei diritti umani. L’ingerenza umanitaria, invece, non solo non è proscritta ma è obbligatoria allo scopo di fare applicare il diritto internazionale dei diritti umani. Evidentemente, un’ingerenza che si giustifica in virtù di norme giuridiche internazionali che vietano la guerra, non può realizzarsi con azioni belliche. Ne discende che, affinchè l’ingerenza umanitaria sia legittimamente esercitabile, debbano essere rispettate le seguenti condizioni.
Primo: i fini devono essere intesi a prevenire la violazione dei diritti umani o a ristabilirne il rispetto. Il ventaglio dei fini è molto ampio, in considerazione del fatto che i diritti umani internazionalmente riconosciuti sono sia quelli civili e politici sia quelli economici sociali e culturali sia quelli dei popoli (all’esistenza, all’identità culturale, alla disponibilità delle risorse naturali sul proprio territorio, all’autodeterminazione). Anche la costruzione o ricostruzione di strutture democratiche rientrano tra i fini che legittimano l’ingerenza. È appena il caso di ricordare che la democrazia ancorata al paradigma dei diritti umani è tutta la democrazia: politica ed economica, rappresentativa e partecipativa, nazionale e internazionale.
Secondo: l’istituzione che decide e realizza l’ingerenza deve essere l’Organizzazione delle Nazioni Unite o altra istituzione internazionale ad essa gerarchicamente collegata.
Terzo: la gestione e il comando dell’intera operazione di ingerenza umanitaria devono essere assicurate dall’ONU in quanto tale, devono cioè avere carattere di «autorità sopranazionale» e non di «coalizione multinazionale» sotto comando e bandiera di uno degli stati membri della coalizione.
Quarto: l’eventuale impiego di personale e strumenti militari deve avvenire esclusivamente per ragioni di polizia, cioè per prevenire atti delinquenziali e neutralizzare forze che fanno uso delle armi. Perchè si tratti di operazioni di «ordine pubblico» e non di «guerra», occorre pertanto garantirsi che l’uso della coercizione avvenga effettivamente per i fini umanitari che legittimano l’ingerenza e nei limiti della legge internazionale dei diritti umani: ciò può essere, giova ribadirlo, soltanto se il comando e la gestione delle operazioni sono esercitati dall’ autorità sopranazionale dell’ONU.
Giova fare presente che la enunciazione del principio di ingerenza umanitaria (o per questioni attinenti alla cosiddetta «dimensione umana») si trova in importanti documenti di organismi internazionali quali il Parlamento europeo, la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, CSCE (in particolare, Conferenza sulla dimensione umana, Mosca, ottobre 199l), lo stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a cominciare dalla risoluzione 688 riguardante la situazione dei Kurdi. Lo stesso principio è ampiamente illustrato dalla Risoluzione di Santiago di Compostella, elaborata nel l989 dal prestigioso «Institut de Droit International», da un documento della Commissione diritti umani della Helsinki Citizens Assembly, HCA (Assemblea dei Cittadini di Helsinki, settembre 1991). Esso figura da ultimo nel documento politico (elaborato dal Centro diritti umani dell’Università di Padova), che i «Beati i costruttori di pace» hanno recato a Sarajevo.
Se il principio di ingerenza umanitaria viene interpretato prescindendo dal diritto internazionale dei diritti umani cui appartiene e lo si applica per coprire «vecchie» intenzioni e logiche di potenza (politica, militare ed economica), siamo evidentemente fuori dalla legalità e si corre il rischio di avventure senza ritorno. La Risoluzione 794 con cui il Consiglio di sicurezza autorizza il Segretario generale e gli stati membri delle Nazioni Unite «a usare tutti i mezzi necessari» per consentire le operazioni di aiuto umanitario in Somalia, prospetta una soluzione di ambiguo compromesso: autorizzazione e supervisione complessiva assicurate dall’ONU, con ruolo attivito del Segretario generale e presenza dei rappresentanti di questo nella sede del comando militare in Somalia –, ma «comando unificato» esercitato dagli Stati Uniti. Non ci siamo ancora quanto a vera «autorità sopranazionale». È certamente necessario intervenire in situazioni come quella della Somalia, non si è intervenuto o si è in forte ritardo per altre situazioni, ma ci si decida, una volta per tutte, a intervenire nel rispetto della nuova legalità dei diritti umani. Si dia quindi subito all’ONU un proprio autonomo strumento di dissuasione e, ove necessario, anche di intervento a fini umanitari secondo quanto previsto dall’articolo 43 della Carta delle Nazioni Unite. Nel richiamare gli stati all’obbligo di sottoporre, in via permanente, all’autorità e al comando dell’ONU parte del loro personale militare, Si sia però consapevoli che il bisogno di «più autorità» per l’ONU è indissociabile dall’esigenza di «più democrazia» per l’ONU. È, questa, una delle più grandi sfide che si pongono per la maturazione della cultura politica del pacifismo. Con la coraggiosissima, esemplare «ingerenza pacifica» operata nella Bosnia e Erzegovina, i «Beati i costruttori di pace» dimostrano, sul campo, di accettare la sfida.

